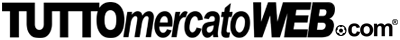ESCLUSIVA TLP - Mi ritorni in mente: Massimo Gadda
 TMW/TuttoC.com
TMW/TuttoC.comLe storie di calcio hanno il pregio di essere tutte originali, seppure all'apparenza uguali. Prendiamo ad esempio quella di Massimo Gadda, che da giovane, appena ventitreenne, sbarca ad Ancona, in una città abituata a fare la spola tra C1 e C2. La serie B nel capoluogo marchigiano manca da più di trent'anni. Un'eternità che viene picconata a forza di vittorie nella stagione 1987/88, con la vittoria del girone B dell'allora C1, pari punti con il Monza (marchigiani primi per la miglior differenza reti).
Massimo Gadda è ad Ancona da circa due anni e già ha iniziato a far sentire il suo peso specifico, in campo e negli spogliatoi. I tifosi si riconoscono in lui e iniziano a vedere nella sua figura, in quella maglia numero otto che corre per il campo, uno di loro. Saranno anni fantastici in cui Gadda prenderà la fascia da capitano e porterà i biancorossi dove mai erano arrivati: la serie A nel 1991/92, allenatore Vincenzo Guerini.
Era il 7 giugno 1992, una parte dello stadio "Dall'Ara" di Bologna era colorata di biancorosso: uomini, donne, bambini e persone di una certa età in lacrime che esterefatte potevano gridare la loro gioia. L'1-1 finale sanciva la certezza matematica.
Per una città come Ancona il vertice della serie A è un sogno che si realizza e Gadda con quella fascia al braccio ne è il simbolo.
Una storia durata otto anni che TuttoLegaPro.com ha voluto farsi raccontare in esclusiva dalla viva voce del centrocampista, attualmente allenatore in cerca di una nuova avventura dopo la promozione con la Spal, ancora fresca nei suoi occhi e culminata con un divorzio consensuale.
Potevamo partire dall'inizio della sua carriera calcistica, ma come detto, gli otto anni di Ancona non possono essere volume in una valigia. E il viaggio con l'ex numero otto biancorosso non poteva che partire dalla città in cui ha scritto le pagine di un capitolo importante del libro del club dorico: quelle dalla C alla A.
Massimo ci parla di questo suo angolo di vita - otto anni sono un lasso di tempo importante - con la stessa emozione di allora, come se il tempo ripensando ad Ancona si fosse fermato.
Non lo dice apertamente, ma c'è un debito di gratitudine nei confronti di questa città che ha imparato ad amare ogni giorno, guardando nel cuore di essa, al punto che la fascia di capitano era d'obbligo. I ricordi scorrono senza bisogno di forzature e quella curva biancorossa del "Dall'Ara" di Bologna, nella partita che ha dato la matematica certezza all'Ancona di arrivare per la prima volta in A, sono il momento più bello.
Mister, tu arrivi ad Ancona nel 1986. Che città trovi?
"Una città bella, vivibile, dove mi sono inserito subito bene. Visto il lavoro che facevo di calciatore, ho trovato persone innamorate della propria squadra del cuore. Gli anconetani sono appassionati e ne hanno viste di tutti i colori. L'anno dopo abbiamo vinto il campionato di C1 (1987/88) arrivando in B. Una serie che mancava da ben 38 anni, quindi ti lascio immaginare l'entusiasmo che si è creato in città".
Quale il segreto di quell'Ancona che andò in B?
"La caratteristica maggiore è stato l'affiatamento di noi stessi. Molti di noi hanno giocato più di un anno con la maglia dell'Ancona e questo ha favorito la compattezza del gruppo. Eravamo calciatori è vero, ma soprattutto amici, avevamo per la maggior parte sui venticinque, ventisei anni. Se penso che oggi ho cinquant'anni, con molti di loro ancora mi sento, mantenendo un rapporto che va oltre l'aspetto professionale. Al di là di questo, c'era la qualità dei giocatori, un allenatore capace e competente che è scomparso poco tempo fa come Giancarlo Cadé. Oltre a questo c'era una società forte e solida, che stava crescendo a vista d'occhio, facendo sì che tutti questi ingredienti, messi insieme, facessero di noi una squadra che poteva solo far bene".
Di solito quando uscivi, quali erano i tuoi posti preferiti in città?
"Ad Ancona intanto c'è il mare, e non è poco. Quando il tempo era bello, il nostro punto di ritrovo era il Conero, Portonovo. Andavamo a mangiare da Emilia, dove il marito Franco ci faceva assaggiare del gran pesce fresco che lui stesso andava a pescare con la barca. Io andavo matto per le lumachine che si tiravano fuori con lo stecchino e quel sughetto che le accompagnava. Una vera prelibatezza".
Ascolta mister, dalla C alla serie A con una finale di Coppa Italia contro la Sampdoria.
"Dopo la conquista della serie B, abbiamo fatto un paio di anni di assestamento. La prima stagione ancora con Cadé come allenatore, poi ci fu l'avvento di Vincenzo Guerini che rimase per cinque anni. Il terzo anno di serie B abbiamo conquistato la Serie A. Un'impresa storica. Una cosa difficile da descrivere, perché ci fu un coinvolgimento totale della città dietro questo evento. Il ricordo più bello che mi lega ad Ancona è stata la trasferta di Bologna che ci diede la matematica certezza di arrivare in A (stagione 1991/92), con una parte dello stadio felsineo tutta colorata di biancorosso. L'anno dopo nella massima serie siamo stati più che altro spettatori, non essendo pronti al grande salto. Anche se siamo retrocessi subito, nessuno ci ha fatto pesare nulla. L'anno successivo abbiamo disputato un ottimo campionato di B, arrivando ottavi e come ricordavi bene, arrivando in finale di Coppa Italia contro la Sampdoria (0-0 al "Del Conero" e 6-0 per i blucerchiati al ritorno al "Luigi Ferraris"). Qualcosa di incredibile anche quello".
Nel calcio di oggi trovare un giocatore che si lega per otto anni in una squadra è quasi un lusso. Ti chiedo: c'è ancora qualcosa che è un lusso nel calcio attuale?
"Qui apriamo un discorso lunghissimo. Io ho fatto il mio primo contratto da professionista a diciotto anni con il Milan. A settembre vado per i cinquantun'anni e da allora sono sempre rimasto in questo mondo e devo dire che un livello di mediocrità come quello attuale non lo ricordo a mia memoria. Anche negli anni '80 abbiamo vissuto momenti difficili, vedi scandalo delle scommesse, però attualmente stiamo toccando un livello veramente basso. Riguarda tutte le componenti. La situazione del paese amplifica il problema e non aiuta. Questo sport ha perso di qualità e se devo pensare a quando ero giovane, c'è una differente gestione del rapporto con chi si affaccia nel mondo del calcio".
Spiegati meglio.
"Voglio dire che i giovani non vengono aiutati e gli viene data l'illusione di essere calciatori e in questo modo oltre a far loro del male, non ci siamo proprio. Dovrebbe essere il merito a premiare, invece non è così".
A tal proposito: Arrigo Sacchi in un'intervista ha dichiarato: "In Italia del merito non ci interessa nulla. L'unica cosa che conta è vincere".
"Sì, sono d'accordo. Purtroppo noi abbiamo questa filosofia del risultato a tutti i costi. Questo aspetto diventa una questione di vita o di morte nelle categorie minori. Soprattutto dalla Lega Pro alla Serie D, diventa drammatica e quindi siamo solo legati al risultato. Devo ammettere che qualcuno sta provando ad apportare dei correttivi, ma in questo paese quando cerchi di cambiare lo status quo in particolar modo, è veramente difficile. C'è anche un altro aspetto poco considerato: la ricerca del risultato come unico scopo va a discapito della qualità del lavoro e delle persone stesse".
Si dice che per essere un allenatore bisogna acquisire la dote della diplomazia, cosa che nel calciatore non c'è o almeno non è richiesta. Lo stesso calciatore vive di emozioni e adrenalina che mal si conciliano a distanza di anni con il ruolo di un allenatore. Per questo ti chiedo cosa hai dovuto mettere da parte del giocatore che sei stato per diventare un tecnico.
"Partiamo dal presupposto che quando sei calciatore, pensi solo a te stesso. Non lo dico in maniera egoistica, ma è un dato di fatto: quando sei in un gruppo non hai la visione completa della situazione e per quanto puoi aiutare un giovane ad inserirsi, hai sempre quell'istinto dentro di te di dover dare il meglio per te stesso in primis. Mentre un allenatore deve essere freddo e resettare subito gli eventi e guardare avanti. Per quanto mi riguarda negli ultimi anni da professionista erano in tanti a dirmi che avrei dovuto fare l'allenatore dopo che avrei appeso gli scarpini al chiodo. E devo ammettere che fare questo mestiere è sempre stata una cosa che mi sono sentito dentro. Il passaggio da calciatore a tecnico è stato meno traumatico. Ho smesso e mi sono subito trovato ad allenare il Baracca Lugo in D. Questa prima esperienza, in un club importante che ha fatto la C e ha visto come allenatore Alberto Zaccheroni, mi ha dato la certezza di aver fatto la scelta giusta. La sensazione di poter far nascere un gruppo, far crescere i giovani, sono delle componenti importanti che ti danno il senso della tua impresa".
Rimango in tema: la differenza tra il fischio d'inizio da calciatore a quello di allenatore.
"Più che al fischio d'inizio, io guarderei la cosa da un altro aspetto: il fischio finale. Quando facevo il calciatore, tale e tanta l'adrenalina che passavo la maggior parte delle domeniche insonne o prendendo sonno quasi alle luci dell'alba il lunedì. Mentre adesso ci sono delle volte che mi addormento sul divano non riuscendo neanche a vedere tutto il posticipo della serie A. Questo per dirti la differenza che passa dal vivere da calciatore e quella da allenatore. Sono due fatiche diverse: da tecnico è più una questione mentale e nervosa, non hai lo sfogo del campo, come il calciatore, il vivere i novanta minuti, la gestione e le dinamiche della partita. Quando l'arbitro fischia l'inizio, da allenatore viceversa, inizi a muoverti nel tuo spazio e cerchi di essere freddo, cercando di non farti coinvolgere emotivamente".
Non credi che per il sistema calcio, per come è strutturato, un giocatore debba essere per forza di cose un bambino mai cresciuto? Non riusciamo a vedere il calciatore come un uomo, ma c'è nell'immaginario collettivo il volto di un bambino, magari viziato, che non cresce mai.
"Questa purtroppo è l'etichetta che si porta il calciatore. Soprattutto per la gente comune. Uno viziato, che non sa cosa sono i sacrifici. In realtà non è così. Quando parli di un calciatore che ha fatto di dieci anni in serie A e uno che ne ha fatti altrettanti in Lega Pro, c'è una distinzione abbastanza netta. A grandi livelli non tutti i grandi campioni che arrivano sono dei bambini viziati, anzi, secondo me, hanno fatto dei sacrifici, dando la giusta importanza a questa parola. C'è da dire che con il passare degli anni, la figura del calciatore si è molto evoluta. Ho avuto compagni di squadra e tanti ragazzi che ho avuto modo di allenare che non mi hanno dato l'idea del viziato, anzi tutt'altro. Con questo non voglio dire che sia solo una voce di popolo campata per aria. Questo avviene quando non ci si rende conto della fortuna che hai. Intanto fai la cosa che ti piace, è ben remunerata, ti fa vivere bene. Alcuni non lo capiscono e hanno degli atteggiamenti che rafforzano l'immaginario collettivo del viziato".
Parliamo dei giovani: non pensi che mal si combaci con la crescita di un giovane la ricerca del risultato a tutti i costi, di cui parlavamo prima? Si dice che il giovane ha bisogno di tempo e di sbagliare, ma così facendo non lo si mette in difficoltà, impedendogli quel percorso di crescita che è il fulcro del loro utilizzo?
"Assolutamente sì. Questo avviene in particolar modo per quei ragazzi che dai settori giovanili dei club maggiori passano a società di D o Lega Pro. Questi ragazzi vengono catapultati in una dimensione a loro sconosciuta. Non sanno cosa significa render conto ad una società, una tifoseria. Il calcio degli Allievi o Primavera, è diverso, vissuto senza pressioni. E molti vengono mandati allo sbaraglio, chiedendo loro di fare campionati da adulti e loro malgrado non sono pronti. Sia mentalmente che fisicamente e tecnicamente. Avrebbero bisogno di un percorso diverso per capire se possono fare il calciatore. E allora ti accorgi che qualcuno è messo lì per la valorizzazione della società, qualcun altro perché porta sponsor. Fermo restando che c'è l'obbligo di fare dei risultati e non dimenticare che rappresenti una città. Devi comunque portare un prodotto di qualità, non è semplice con questi giovani".
La paura è più una risorsa o un impedimento?
"La paura è una risorsa. Quelli che dicono di non aver paura, di non aver paura di nulla, sono i primi che se la fanno addosso. La paura deve esserci e va affrontata con coraggio. Quando c'è un obiettivo da raggiungere, vedi una salvezza o un campionato da vincere, ti aiuta a tenere alta la concentrazione".
Lavorando con i giovani, c'è il rischio concreto che qualcuno di loro non abbia gli attributi giusti per vivere un'emozione come un obiettivo importante. Come cerchi di tranquillizzarlo in questi casi?
"Cercando di renderlo consapevole dei propri mezzi. La cosa fondamentale che un allenatore deve fare con un ragazzo è non raccontargli favole: se uno si accorge che questi non ha i mezzi per arrivare, glielo deve dire. Con i giusti mezzi, ma va fatto per il suo bene. Senza dare ulteriori illusioni. Ci sono dei ragazzi che possono fare il salto, in B o in A. Ad ognuno di loro va fatto comprendere il valore della parola sacrificio e che non bastano le qualità tecniche, ma c'è un lavoro globale - a livello mentale in particolar modo - che va fatto per far sì che possa arrivare dove pensi che meriti".
Tornando a te: cosa ti ha insegnato lo sport?
"A come si sta con gli altri. Uno sport di squadra come il calcio ha questa capacità: farti migliorare nel confronto con persone e caratteri diversi dal tuo e tu impari con il tempo a viverci e conviverci. A non avere una visione della vita egoistica. A come affrontare le difficoltà e avere i mezzi per aiutare un compagno in difficoltà".
Pensi di esserti ritirato al momento giusto?
"Alla fine sì. L'ultimo anno ho giocato nei dilettanti a Fano (stagione 2001/02), avevo quasi 38 anni. Avevo fatto un buon campionato a livello fisico e nel frattempo stavo prendendo il patentino di seconda categoria da allenatore. Mi è arrivata quest'offerta dal Baracca Lugo e in poche ore ho mollato tutto e alla fine è stata la scelta giusta. Intanto mi ha permesso di non avere tempi morti tra la fine e l'inizio di una nuova carriera, al punto che non me ne sono neanche accorto. Questo mestiere mi è piaciuto fin da subito, mi dava entusiasmo e sono soddisfatto della scelta fatta".
Ogni tanto ti guardi indietro? E cosa ci trovi?
"Mi guardo indietro sì, ma solo per rivivere i momenti belli della mia vita. Se è vero che non si vive di ricordi, devo dire che le emozioni del passato sono sempre un ottimo stimolo per guardare al futuro con più ottimismo. Mentre da un altro punto di vista non mi guardo mai indietro quando devo prendere una decisione. giusta o sbagliata, la vivo. Vengo da un'esperienza importante alla Spal e nonostante non sono stato riconfermato, guardo avanti con fiducia".
Il gol a porta vuota che hai sbagliato nella tua vita?
"Ho avuto delle occasioni da allenatore che mi sono sfuggite di un niente, ma non dipende da me, ma sono delle persone che devono scegliere, quindi non ho un rammarico in particolare".
C'è un giocatore che ti ha fatto perdere la testa in una partita di calcio?
"Mi ricordo un Cesena-Livorno. Finì 4-0 per noi. C'erano ventimila persone, di cui diecimila da Livorno. Ho litigato tutta la partita con Ennio Bonaldi, attaccante dei labronici. E' stato un delirio di insulti".
Se il numero dieci nel calcio è vissuto come il violinista, uno come Gadda, uno di quelli che ha la maglia numero otto come te, come possiamo definirlo?
"Sono nato trequartista e ho pagato dazio per il fatto che amavo gigioneggiare con il pallone. Chi mi ha cambiato di ruolo, facendomi diventare un metodista davanti alla difesa è stato proprio Giancarlo Cadé ad Ancona. Fatte le dovute proporzioni, sono diventato il Pirlo biancorosso in quella squadra. Diciamo che quelli come me, sono dei numeri dieci travestiti dalla maglia numero otto".
La differenza, se esiste, tra campione e fuoriclasse.
"Non è semplice rispondere. Sono due definizioni che vanno di pari passo. Il fuoriclasse è colui che ha ricevuto da madre natura dei colpi unici. Penso che le due cose vadano di pari passo: il campione mi pare più completa come risposta. Un campione in fondo deve esserlo in campo e fuori. Ci sono i fuoriclasse in ogni categoria: ad esempio uno che in B fa il fenomeno, ma se arriva in A non si esprime come potrebbe. Ognuno è un fuoriclasse nella propria categoria. Anche io nel mio piccolo in B o C ero, a detta di molti, uno di un livello maggiore. E difatti appena ho visto la A, si vedeva la differenza di qualità".
Sei notoriamente un grande appassionato di tennis, tifosissimo di Roger Federer. Cosa ha questo sport che manca al calcio?
"Bella domanda! Credo che attualmente il tennis abbia un fair play che al calcio manca. E' vero che è uno sport singolo, difficile da paragonare al calcio. Quello che mi sorprende dei tennisti è la forza mentale. Stanno lì, quattro, cinque ore, sono sul pezzo sempre. Ammiro campioni come Federer, che nonostante abbiano vinto tutto, sono ancora lì sul campo che combattono come se fossero dei novelli del tennis".
Rimaniamo nel campo delle differenze: se il tennis i campioni li produce, perché a tuo parere il calcio italiano non riesce a sfornare giocatori che possono fare il salto di qualità?
"E' un discorso lungo e pieno di ostacoli. Credo che il giovane di oggi, parlo di ragazzi di 10-11 anni, venga cresciuto senza la passione per il calcio, come ce l'avevo io. Partiamo da questo. Mi spiego meglio: spesso parlando con mio figlio che gioca in D (nel Matelica, ndr), gli dico: "Ai miei tempi, ai miei tempi". Capisco che sono generazioni a confronto la mia e la sua che non combaceranno mai. Però io sono cresciuto nel cortile di casa, la strada mi ha fatto da seconda maestra. Nessuno mi dava regole, ce le facevamo noi. Chi portava il pallone decideva, le porte le facevamo con i sassi. Era una palestra importante. A 14 anni sono andato al Milan, rimanendo fino a 20 anni. E mi è servito tantissimo. C'è un altro aspetto non marginale: ci sono molti motivi per non appassionarsi al calcio, viste le tante cose che la società di oggi ci offre. E non credo neanche che i camp estivi possano dare un contributo alla crescita di questi ragazzi, anzi penso che queste forme di aggregazione di tanti ragazzi siano un altro modo per fare del business. E alla fine, la qualità volenti o nolenti, si abbassa notevolmente. Con tutti i modelli che si vedono in giro, un ragazzo perde lo stimolo a sacrificarsi e alla lunga mollano la presa. Per recuperare il terreno perduto ci vogliono persone di qualità, istruttori preparati, non possiamo lasciare tutto al caso".
Un'ultima cosa: hai ancora voglia di sognare, arrivato a cinquant'anni?
"Sì sì, certamente. Mi è capitato di pensarci. Da quando faccio l'allenatore mi sono reso conto di quanti ostacoli ci sono per arrivare. Però io non mi arrendo, ho troppa passione per questo sport. Ho troppa voglia di guidare un gruppo, far crescere dei giovani. Ho voglia di arrivare e me lo sento dentro. Non c'è episodio negativo che mi può fermare".
Prossimo appuntamento con "Mi ritorni in mente": domenica 17 agosto

Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore Responsabile: Ivan Cardia
© 2025 tuttoc.com - Tutti i diritti riservati